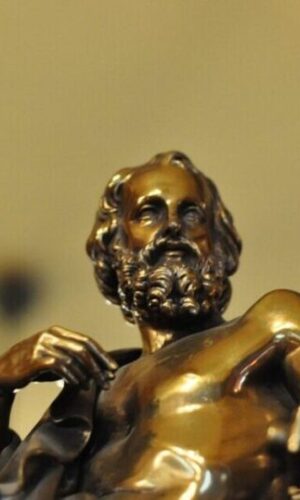Platone e la politica di oggi-Articolo di Carlo Di Stanislao-Biblioteca DEA SABINA
Biblioteca DEA SABINA
Platone e la politica di oggi-Articolo di Carlo Di Stanislao-
Il tramonto dell’utopia: Platone, la Lettera VII e l’assenza del filosofo nella politica di oggi-“Finché i filosofi non saranno re nelle città o coloro che ora sono chiamati re e potenti non saranno filosofi autentici e capaci, non vi sarà fine ai mali per le città né, credo, per il genere umano.”
— Platone, Repubblica, V, 473 a.C.
Ci sono testi che, pur scritti in un passato remoto, continuano a parlarci con una forza sorprendentemente attuale. La Lettera VII di Platone è uno di questi. Non è un dialogo filosofico nel senso stretto, ma è forse il documento più intimo, sofferto e politicamente disilluso che ci sia rimasto del filosofo ateniese. Un testo che mescola biografia, riflessione, autocritica e visione. Un testamento spirituale, ma anche una denuncia. E soprattutto: una profezia.
In questa lunga epistola, Platone racconta – con dolore e lucidità – la sua speranza giovanile di cambiare il mondo attraverso la politica e la filosofia. Una speranza infranta. L’esperienza diretta a Siracusa, con il tentativo fallito di formare un sovrano giusto in Dionisio II, e la tragica fine di Dione, simbolo del filosofo che cerca di tradurre l’ideale nella realtà, segnano il punto di rottura. Non solo nella biografia di Platone, ma nella storia del pensiero politico.
La Lettera VII è il racconto di un fallimento che, lungi dall’essere una resa, si trasforma in una riflessione altissima sul senso stesso della filosofia e sul rapporto – mai facile – tra pensiero e potere. Oggi, a distanza di oltre duemila anni, quel testo ci appare come uno specchio oscuro ma nitido: ci mostra quanto ci siamo allontanati dall’ideale platonico, e ci sfida a chiederci se sia ancora possibile, o desiderabile, recuperarlo.
Filosofia e politica: una promessa tradita
Quando Platone afferma che la giustizia nelle città potrà esistere solo quando i filosofi saranno re, non sta immaginando un sistema utopico nel senso di irrealizzabile: sta descrivendo una necessità antropologica. Per lui, il potere senza conoscenza del Bene è cieco; la conoscenza senza potere è impotente. Ma affinché questa unione si realizzi, serve un cammino lungo e difficile: serve formare l’anima, purificarla, elevarla fino alla contemplazione dell’idea suprema.
Questo progetto, che appare teorico nella Repubblica, nella Lettera VII si scontra con la realtà. Lì Platone racconta il suo impegno concreto, le sue delusioni, i tradimenti subiti. Dione, che aveva creduto in lui, che aveva sognato una Siracusa retta dalla giustizia e dalla ragione, viene assassinato. Platone stesso rischia la vita. Tutto sembra crollare.
Ma non è la sconfitta dell’ideale: è la sua tragica verità storica. La Lettera VII ci insegna che l’ideale del filosofo-re è incompatibile con il mondo dominato dall’ambizione, dalla paura, dalla brama di dominio. La filosofia – che è ricerca disinteressata, amore per la verità, cura dell’anima – viene inevitabilmente espulsa dal campo di battaglia della politica reale. Il risultato? La politica si svuota di giustizia, e la filosofia si rifugia nell’accademia.
Oggi: l’ideale è un relitto
A guardare la situazione attuale, il quadro è sconfortante. La politica contemporanea sembra aver tagliato ogni legame con la dimensione etica, sapienziale e filosofica. I leader non si formano più attraverso la dialettica o lo studio, ma attraverso le logiche del marketing, della comunicazione istantanea, dell’immagine.
La verità non è più ciò che guida le decisioni pubbliche: è diventata un ostacolo da aggirare, un concetto “relativo”, una parola sospetta. Il potere – sia politico che economico – si muove senza riflettere, senza guardarsi allo specchio, senza domandarsi se ciò che fa sia giusto. Manca la consapevolezza che la gestione della polis richiede virtù, conoscenza, disciplina interiore.
Anche la filosofia, dal canto suo, si è in parte arresa. Spesso si è rinchiusa nelle università, ha accettato il ruolo di materia marginale, ha smesso di incidere sulla formazione dei cittadini e dei governanti. Non viene più percepita come stile di vita, come esercizio dell’anima, ma come curiosità intellettuale, come specializzazione astratta.
La distanza da Platone, dunque, non è solo culturale: è esistenziale. Il suo sogno di un potere illuminato dalla filosofia è oggi inaudito, estraneo, quasi ridicolo agli occhi del mondo politico e mediatico. Eppure, proprio per questo, la sua visione può rivelarsi ancora profetica.
Il sapere come trasformazione dell’anima
Un passaggio cruciale della Lettera VII riguarda la natura della conoscenza. Platone distingue tra opinione, apprendimento meccanico e conoscenza autentica (epistéme). Quest’ultima non può essere scritta, né trasmessa attraverso parole: deve essere vissuta, intuita, come un bagliore interiore che nasce da un lungo processo di dialogo, esercizio e purificazione.
Questa concezione della conoscenza come esperienza trasformativa è agli antipodi della concezione contemporanea del sapere come insieme di competenze. Oggi, nella scuola e nell’università, si parla sempre più di skills, performance, output. Si misura tutto, ma si dimentica l’anima. Eppure Platone ci ricorda che sapere non è sapere che cosa, ma sapere chi siamo.
In un mondo frenetico, centrato sull’efficienza e sull’utilità, la filosofia platonica ci riporta alla lentezza, all’interiorità, alla fatica della verità. Ci dice che la formazione non è addestramento, ma educazione spirituale. E che senza questa educazione, nessun potere sarà mai davvero giusto.
Il fallimento come verità dell’ideale
La morte di Dione, che Platone racconta con dolore e ammirazione, è il simbolo tragico del fallimento dell’ideale politico platonico. Ma non è una fine, è una rivelazione. È la conferma che chi cerca la giustizia può essere sconfitto, ma non deve rinunciare. L’uomo giusto, dice Platone, anche se perde, resta giusto.
In questo senso, la Lettera VII è un testo eroico. Non predica la vittoria, ma la fede nella giustizia anche nella sconfitta. È un invito a vivere la filosofia non come rifugio, ma come missione. Non come teoria, ma come scelta di vita. Anche a costo dell’esclusione, del ridicolo, del pericolo.
Platone non rinuncia all’idea del Bene. La sottrae al compromesso. La affida al tempo. E ci dice: “la politica vera si fonda sulla filosofia, oppure è solo amministrazione del caos.”
Un’eredità ancora viva (se lo vogliamo)
Molti hanno letto la Lettera VII come una resa. In realtà è un atto di accusa, una meditazione sul fallimento e una sfida lanciata ai posteri. Platone sapeva che il suo ideale era fragile. Ma sapeva anche che la civiltà si costruisce proprio attorno a ideali che non si realizzano del tutto, ma che indicano la direzione.
Nel mondo moderno, autori come Nietzsche, Heidegger, Arendt, Popper, Strauss, Hadot si sono confrontati – ciascuno a suo modo – con l’eredità platonica. Alcuni l’hanno criticata, altri l’hanno rivalutata, altri ancora l’hanno trasformata. Ma tutti hanno dovuto fare i conti con quel sogno antico: la fusione di sapienza e potere.
Oggi, in tempi di crisi democratica, di leadership vuote, di populismi e tecnocrazie, il pensiero platonico può tornare ad avere una funzione decisiva: non come ricetta, ma come domanda radicale. Cosa significa governare? Chi è davvero degno di comandare? Qual è lo scopo della politica?
Conclusione: tornare al fuoco
Nel buio dei tempi, Platone immaginava un fuoco. Non un fuoco che brucia, ma che illumina: quello della conoscenza vissuta, della verità cercata, del Bene contemplato. Un fuoco che si accende nell’anima di chi filosofa, e che può – forse – irradiare la città.
Oggi viviamo in una società che ha spento quasi tutte le fiamme dell’anima. Ma la Lettera VII ci invita a custodire almeno una scintilla. A non dimenticare che la filosofia non è un lusso, ma una necessità. E che senza di essa, la politica resta cieca.
Forse Platone ha fallito. Ma se vogliamo una politica degna dell’uomo, dobbiamo cominciare proprio da quel fallimento. Non per arrenderci, ma per riscoprire la grandezza dell’ideale. E, magari, per iniziare – nel nostro piccolo – a viverlo.
Articolo di Carlo Di Stanislao
Foto di mvivirito0 da Pixabay